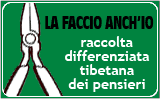A quel punto, Maya capisce che qualcosa non va.
– Qualcosa non va? – chiede. E mio padre, impassibile: no, perché?, e tira su il ferro da stiro rovesciando la piastra verso l'alto, e facendo uscire un getto rabbioso di vapore. Maya, sforzandosi di parlare lentamente e con calma, gli chiede di staccarlo, il ferro. Lui, per tutta risposta fa uscire un getto d'acqua con lo spruzzino verso di lei. Lei che caccia un urlo.
– Qualcosa non va? – le chiede lui, calmo.
Allora lei non regge la tensione, scoppia in singhiozzi. Mio padre riprende tutto posato a tostare la camicia sull'asse. Senza guardarla le dice:
– Mi tradisci.
Lei singhiozza più forte, mugola un no tra i singulti. Mio padre fa uscire un ruggito di vapore dal ferro da stiro.
– Dimmi la verità, o ti stiro – le dice piano, senza guardarla.
– No, ti prego.
Per tutta risposta mio padre ruota il pomello del ferro da stiro, alzando la temperatura. La camicia urla di dolore sotto la piastra. La stanza si riempie di vapore e bruciore. Maya smette di singhiozzare e dice sì, è vero, ti tradisco. E mio padre le dice: lo so, mica te l'avevo chiesto. Non c'era il punto di domanda. Hai visto qualche punto di domanda nell'aria piena di vapore e bruciore? No, non c'era nessun punto di domanda, era un'affermazione la mia. Tu mi tradisci, ti ho vista al mercato cinese ieri. E a quel punto lui alza gli occhi su di lei, e lei ribatte dicendo una cosa assurda, insensata.
– Non abbiamo comprato niente – dice.
Mio padre non si aspettava questa affermazione. Che modo di ribattere è? Anche il ferro da stiro smette per un attimo di eruttare vapore. Mio padre allora si mette a ridere.
– Sul serio ti sei messo a ridere?
– Non fa ridere? A me ha fatto ridere. E mentre ridevo mi sono reso conto improvvisamente che erano mesi che non ridevo. Che non ridevamo. Che ci stavamo a fare lì, io e lei, sulla collina di Vladivostok, senza mai incontrarci se non sulle scale? Che ci stavamo a fare se non ridevamo neanche più?
Allora in quel momento pure a Maya è scappato un sorriso. Un sorriso triste. Di quelli che è impossibile descrivere, e infatti non esiste mica l'emoticon per quel sorriso triste lì, non esisterà mai la faccina con quel tipo di sorriso lì, e questa, almeno per me, è una consolazione.
Due giorni dopo, Maya ha lasciato la casa ed è andata a vivere con il soldato russo. Mio padre ha cominciato a fare delle gran passeggiate da solo, prendeva la funicolare su fino al Monte del Nido dell'Aquila, e da lassù guardava la città, i giganteschi ponti e l'oceano, le vecchie navi militari nel porto.
– A che pensavi?
– Mi veniva voglia di prendere quelle navi militari, quei sommergibili, di salpare per la Kamčatka e da lì sferrare un attacco all'Alaska.
Poi un giorno Svetlana, la cameriera della pizzeria dove lavorava, lo ha invitato al suo compleanno a casa sua. Lei viveva in un piccolo appartamento in un grosso e grigio caseggiato della periferia vladivostokiana, dove si era trasferita dopo il divorzio. Alla festicciola c'erano anche gli altri colleghi di lavoro. Su un tavolino c'era una bottiglia di vodka, e un samovar elettrico con del tè. A una certa ora gli ospiti cominciarono ad andarsene, uno dopo l'altro, e rimasero solo mio padre, Svetlana, la vodka e il samovar vuoto. Andarono avanti tutta la notte a parlare, Svetlana perché era sbronza, mio padre perché era strafatto di caffeina.
– Vuoi dire teina.
– La teina non esiste. È un'invenzione della Clebbino. Si chiama caffeina, anche quella che c'è nel tè.
– A proposito, ho sempre pensato che la mia moka fosse nera, invece indovina? Non era nera, era solo sporca.
Parlavano un misto di anglo-russo-italiano pieno di gesti con le mani e di facce con la faccia, e si capivano benissimo, e sono andati avanti fino all'alba, e a quel punto l'effetto della caffeina e della vodka stava svanendo, e così mio padre ha detto che forse per lui era ora di andare, e allora Svetlana l'ha accompagnato alla porta, l'ha ringraziato e gli ha detto che quello era stato il compleanno più bello della sua vita. E sulla porta si sono abbracciati. E poi mio padre è uscito, fuori la temperatura era molto sotto lo zero, si è girato e ha guardato il casermone grigio stagliarsi contro il cielo dorato da un'alba vladivostokiana...
– Falla corta, babbo.
E niente, dopo un mese si sono sposati.
– Che cosa?
– In una chiesetta ortodossa.
– Ti sei sposato? Con Svetlana?
– Certo, con chi altri? E tra un mese – il tempo di sistemare un po' di cose – si trasferirà qua.
– Qua dove?
– Qua. In Italia. A casa mia.
– Qua? Nella casa di mio padre e mia madre?
– Tua madre è morta.
– E con questo?
Non potevo crederci. Io in due anni e mezzo nella Zona Deumanizzata non avevo combinato assolutamente niente, e nello stesso arco di tempo mio padre aveva attraversato la Russia in treno, aveva convissuto con una donna, si erano lasciati, aveva conosciuto un'altra donna e se l'era sposata. E adesso era tornato. E tra un po' lei sarebbe venuta a vivere da lui. E mia madre era morta. Ok, quest'ultima cosa non era successa negli ultimi due anni e mezzo, ma restava pur sempre valida: cioè, mia madre continuava ad essere morta. Anche adesso è morta, per dire.
– Tu fai le cose sempre di testa tua eh? A me non ci pensi mai neanche un secondo eh?
– Ho 65 anni! Devo chiedere il permesso a 65 anni?
– E io alla mia età devo ritrovarmi con una matrigna? Ma siamo matti, siamo. Non esiste. Perché non siete rimasti là? Perché non ti sei rifatto una vita a Vladivostok? Perché devi venire a rifartela qua, dove ci sono io, con tutti i miei ricordi? Lasciami i miei ricordi e tornatene a Vladivostok!
– Bada a come parli. Sono pur sempre tuo padre! Ricordati che neanche tanto tempo fa ero io a pulirti il culo!
– E tu ricordati che tra qualche anno sarò io, a pulirtelo!
In caso di bomba atomica
6 anni fa




.gif)