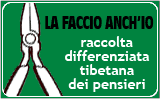Da quando il maestro si è piazzato – a questo punto posso dire, con cognizione di causa, abusivamente – a casa mia, cerco il più possibile di stare lontano da casa mia, non senza una certa sofferenza per la lontananza da Dolly. Vado spesso a pranzo da mio padre, dopo pranzo ci facciamo delle passeggiate, muoviamo un passo dopo l’altro (il modo classico di passeggiare) per i marciapiedi del suo isolato e di quelli contigui, passiamo davanti ai cassonetti della raccolta differenziata che mi strappano un sorriso amaro perché mi ricordano la RDTP e il mio maestro che occupa abusivamente casa mia impedendomi di fatto di chiavarmi in santa pace la mia pecora gonfiabile, passiamo davanti ai negozi sfitti, alle saracinesche abbassate, ai muri scacazzati di tag di writers da quattro soldi, tra i quali qualcuno ha scritto con uno spray giallo WAKE ME WHEN IT’S QUITTING TIME. A un certo punto guardo mio padre – non lo guardo spesso, di solito mi limito a guardargli intorno, a guardare dalle sue parti, senza metterlo davvero a fuoco, faccio così con tutte le persone che credo di sapere a memoria, quelle che penso che ci saranno sempre, mentre un bel giorno non ci saranno più – guardo mio padre, vedo una bomboletta spuntare dalla tasca del suo bomber. Il suo bomber lo fa sembrare un pilota d’aereo che abbia seguito la procedura di espulsione dal suo aereo e sia precipitato su questo marciapiede dove ora stiamo mettendo un passo dietro l’altro, senza che il paracadute si sia aperto.
– Sei tu che scrivi sui muri? – gli chiedo, indicando la bomboletta, non è che ci credo davvero mentre lo chiedo, anzi non ci credo per niente, ma sento di doverlo chiedere, o sarebbe l’ennesima cosa non chiesta che un giorno rimpiangerei di non aver chiesto.
– No, questa non è una bomboletta di vernice, questo è svitol.
Annuisco, annuisce pure lui, contento del mio annuire. Annuisco di rimando e lui altrettanto, anche se con meno entusiasmo. Allora smetto di annuire e comincio a scuotere la testa.
– Non esco praticamente più senza lo svitol – dice.
Io scuoto la testa.
– Da circa un mese. È sempre con me, nella tasca del mio bomber. Lo svitol è fondamentale.
– Come arma di autodifesa?
Mio padre mi guarda. A differenza di me, lui non mi guarda intorno, o nei pressi, lui mi guarda dritto in faccia, quasi sempre. Dev’essere una cosa dei padri, che guardano in faccia i figli, e dev’essere una cosa dei figli, che sfuggono la faccia e la figura dei padri.
– No – dice, – come lubrificante. Come sbloccante. Come solvente. Come disossidante. Come detergente. Come…
– Ok ok ok, chiaro.
Mio padre si ferma. Mi tocca un braccio addirittura.
– Lo svitol è nato nel 1938. Ha 10 anni più di me. Quando sono nato, lo usavano già da 10 anni per la manutenzione dei tram di Milano.
– Senti, io…
Vengo interrotto da un guaìto infernale. Siamo arrivati davanti ai giardinetti, e in mezzo a un’aiuola c’è una bestia orribile, una creatura satanica, con otto zampe e due teste.
– Poverini, sono rimasti attaccati – dice una vecchia seduta su una panchina lì vicino.
– Dorabel! Dorabel! – chiama lamentosamente un’altra signora, rivolta verso una delle teste della creatura. Guardo meglio e mi rendo conto che sono due cani, rimasti sessualmente incastrati.
Rido: non posso farne a meno, e la padrona di Dorabel mi fulmina con uno sguardo. Mio padre estrae dalla tasca lo svitol.
No, penso.
Mio padre toglie il coperchio di plastica allo svitol.
No, non può essere, penso.
Mio padre scuote lo svitol.
No, ti prego no, non farlo, penso.
Mio padre si avvicina alla cagnara, si abbassa, puntando lo svitol. La cagnara ruota su se stessa, come una trottola, poi si ferma, come intuendo qualcosa. Mio padre ruota la bomboletta, la posiziona quasi rasoterra, la accosta al punto di congiunzione della cagnara, spruzza.
Io chiudo gli occhi.
Un latrato riecheggia tra gli isolati.
Apro gli occhi. Vedo i due cani finalmente separati, Dorabel tra le braccia della sua padrona, l’altro – il cane chiavatore – è scappato umiliato oltre la siepe e da lì chissà dove.
– Lei è un eroe – dice la padrona di Dorabel a mio padre. Mio padre rinfodera lo svitol, e senza dire una parola riprende a camminare. Lo raggiungo.
– Ma non è, tipo, tossico – provo a dire.
Mio padre alza le spalle: – La vita, è tossica – dice.
Sì, vabbè, penso. Scrivilo sui muri, penso. Poi mi viene in mente una cosa.
– Senti, babbo. Non te l’ho mai chiesto.
Mio padre mi guarda in faccia, di nuovo. Io, che già mi sento in imbarazzo per la cosa che sto per dire, mi imbarazzo ancora di più.
– Quella storia di zio Piero e zia Scimunetta. Quella cosa che si dice.
– Quale.
– Oh, andiamo.
– Quale.
– Lo sai benissimo quale.
– No. Che intendi dire?
– Quella storia che si racconta di loro… che una volta sono finiti al pronto soccorso… che erano a letto e insomma, è successo come quei cani.
– Stavano scopando e sono rimasti attaccati?
Niente, mio padre proprio non sa girarci intorno alle cose, deve sempre andare al punto, dichiararlo, metterci magari anche il timbro di ceralacca.
– Sì, be’, lui se la stava inculando e…
– Ehi. Ehi. Un po’ di rispetto per i tuoi zii.
– Cosa? Ma sei tu che hai detto che stavano scopando.
– Mai sentita. E comunque, non è vera. Gli esseri umani non possono rimanere attaccati. Leggende urbane. Ma davvero credi a queste storie?
Adesso è lui che scuote la testa.
Sono quasi sicuro di averlo visto sorridere, per un attimo.
In caso di bomba atomica
6 anni fa




.gif)